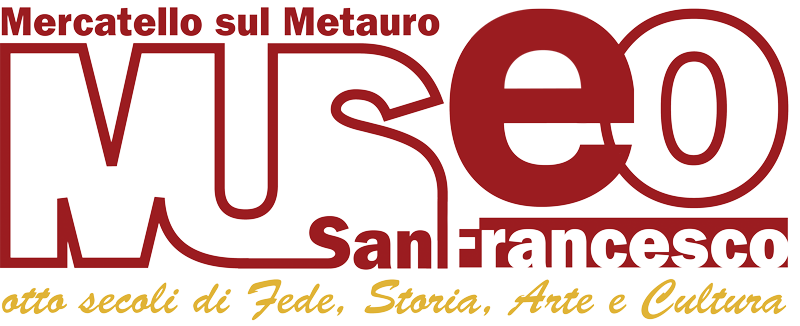
La chiesa di San Francesco fu destinata ad accogliere opere del territorio fin dal 1926, anno in cui terminarono i restauri che la riportarono all’originaria semplicità francescana. L’accrescimento delle collezioni e le revisioni degli allestimenti hanno portato in seguito a liberarla dalle opere decontestualizzate e ad ampliare gli spazi espositivi che ora occupano gran parte dell’ex-convento francescano.
Il percorso museale presenta opere d’arte di straordinario valore e si snoda in suggestivi spazi architettonici, presentando una sintesi delle testimonianze storico-artistiche prodotte o commissionate nei secoli dalla comunità cristiana locale, attraverso dipinti, sculture e oggetti liturgici.


